di Claudia Grande

© Felice Vino, Abyss
Mi chiamo Claudia. Ho 33 anni. Sono del segno del Capricorno. Ho scaricato un’app, Costar Astrology, che mi dà consigli su come impiegare le mie giornate in base a certi complicati calcoli astrologici (i.e.: ardite elucubrazioni di un algoritmo che pesca massime dal ventre gorgogliante del web). Una mattina, Costar mi ha detto: «Kill your personal branding». Ci ho riso su, non sono mica Chiara Ferragni. Quella frase, però, ha continuato a rimbalzarmi nella testa; del resto, i social occupano quotidianamente il mio spazio interiore, il mio tempo. Ho notato che il mio mondo digitale sta plasmando a sua immagine quello reale, e pensarci mi ha fatto paura, ma non è sempre stato così. Ci sono stati un prima e un dopo, come in tutte le storie; e in mezzo una lunga serie di rimuginii.
Il 14 maggio 2023 una persona mi ha insultata perché pubblico sui social foto mezza nuda. Ho reagito in un modo a me estraneo: ho scritto una riflessione su Facebook, condividendo non solo la mia esperienza personale, ma anche la mia opinione su alcune rivendicazioni di matrice femminista – come, ad esempio, il diritto di mostrare il mio corpo senza essere etichettata come poco di buono, stupida, puttana, una vergogna per i genitori. Fino a quel momento, non avevo mai parlato della mia intimità su Facebook, né avevo preso una posizione tanto esplicita su temi attuali e, per così dire, seri. Ho sempre pensato: i social non sono seri. I social servono a divertirsi, a postare meme, canzoni, libri, cose che ci piacciono, che ci strappano una risata o un like e poi basta, finita lì. Dal 14 maggio 2023, tutto è cambiato: i social sono diventati il luogo per raccontare me stessa, i miei valori, la mia prospettiva su ciò che mi circonda; ed ecco che postare ha assunto un peso specifico. Prima, i social mi attraevano perché si pongono come un antidoto alla noia e alla solitudine; perché gratificano il mio ego, bisognoso di continue conferme; perché mettono un bavaglio al vuoto interiore che grida anche quando non vorrei ascoltarlo. Potevo sconfiggere la solitudine, prima, sentendomi apprezzata e capita; potevo colmare il vuoto, seppure con un espediente a efficacia limitata e ad alto tasso di dipendenza. Come la droga. Il meccanismo è simile: è stato accertato che, a livello neurologico, osservare i like che crescono stimola la produzione di endorfine, serotonina e ossitocina. Non appena la scarica si esaurisce, è normale volerne ancora. È umano preferire il piacere al non-senso.
Oggi, per me, postare non è un piacere. È un dovere. Di più: è un obbligo morale.
Se non dico la mia sull’argomento del giorno, sono superficiale, disimpegnata, non si capisce da che parte sto. Se non parlo di quello che la mia community vuole, esattamente nel modo in cui la community si aspetta che io ne parli, sono disattenta, deludente, un cattivo esempio – ed ecco che scattano il defollow o la shitstorm. Se ribatto ai commenti astiosi con altrettanta rabbia, sono maleducata, incapace di gestire le emozioni; se sto zitta, tentando di evitare lo scontro, sono pavida; se cancello i commenti non graditi, non so accettare le critiche. Se non rispondo alla domanda di Facebook: «A cosa stai pensando?», gli altri lo faranno al mio posto. Riempiranno le righe come vorranno, restituendomi un diario imbrattato di presunzioni che, davanti al mio silenzio, potrebbero tramutarsi in stentoree certezze.
Gli altri: chi sono? Le stesse persone con cui condividevo meme, film, foto delle vacanze, rispetto a cui ora mi sento in dovere di spiegare.
Cosa? Me stessa. Ogni minima sfaccettatura del mio essere.
Se la spiegazione funziona, provo sollievo: non mi hanno tagliato la testa.
Ma domani, che succederà?
Potrei dire la cosa sbagliata. Non perché lo sia, a rigor di logica, ma perché la maggioranza degli utenti con cui interagisco non la pensa come me. E allora?
Allora, dovrei dire addio alla testa. Dovrei pagare col sangue, perché avrei dimostrato di essere imperfetta, fallibile, sbagliata. Non c’è spazio per l’errore: benvenuta nell’arena.
Ma io non voglio fare del male agli altri. Allora sei buonista!
Ma io non voglio fare del male a me stessa. Allora sei codarda!
Ma io non voglio essere trattata con tutta questa ferocia. È il gioco di Internet: se non sei pronta a lasciarci la pelle, è meglio non giocare!
Kill your personal branding, penso: uccidere prima che mi uccidano.
E sia.
Lungi da me contraddire le stelle.

© Felice Vino, Jellyfish
Bulimia mundi
Per capire come e quanto il personal branding e l’uso distorto dei social stiano danneggiando noi e il nostro modo di stare nel sociale, bisogna innanzitutto comprendere come e quanto la nostra epoca sia cambiata rispetto al material world cantato da Madonna: ciò che conta si è spostato dal materiale all’immateriale, da ciò che è concreto e tangibile a ciò che, lungi dall’essere metafisico, è incorporeo.
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta si verificò un inanellamento di epiloghi di portata mondiale (la caduta del muro di Berlino, la fine della Guerra Fredda, il declino del movimento hippie e delle rivolte studentesche, ecc.); a queste grandi fini si contrapponevano, in parallelo, l’ascesa del modello capitalista e della cultura massificata, foraggiati dai mass media con un bombardamento di messaggi di consumismo sfrenato, positività martellante e felicità a ogni costo. In un primo momento, quello che poteva sembrare solo ingenuo ottimismo era stato, più che altro, un contraltare al disfattismo susseguente ai conflitti mondiali; in un secondo momento, tuttavia, i valori prefabbricati dalla televisione e dalla pop-art fecero da megafono alla propaganda capitalista, permettendole di prosperare. Cosa c’entra tutto questo con i social? Si potrebbe dire che, in modo indiretto, ma prevedibile, questo nuovo modello socioculturale ne abbia fondato le basi.
Il filosofo e sociologo Jean Baudrillard afferma che il consumo, all’epoca (la sua epoca), era la forma prediletta di comunicazione. Gli oggetti erano simboli di un codice che: (i) permetteva ai consumatori di riconoscersi attraverso il possesso dei loro corpi inanimati, lanciando impliciti messaggi legati al proprio benessere, al proprio status sociale, alle proprie ambizioni, alla propria voglia di farsi osservare, non solamente vedere; (ii) quello stesso codice serviva a catalogare gli esseri umani, perpetuando e aumentando le differenze di classe, rendendole esplicite senza che vi fosse bisogno di parole. Ed ecco che nasceva, silenziosa e dirompente, una meta-narrazione del sé, originata dall’intersezione tra merce posseduta e ingrassamento dell’ego attraverso un’esasperata materialità: «Un immenso narcisismo collettivo conduce la società a confondersi e assolversi nell’immaginario che essa si dà di sé stessa, a convincersi di sé stessa, come la pubblicità finisce per convincere le persone del loro corpo e del loro prestigio – in breve, ad autoprofetizzarsi1». È così che Baudrillard prospettava gli esiti di questa dilagante bulimia, ricordando come il centro di quella narrazione restasse pur sempre l’io, la persona dietro l’oggetto, sebbene l’oggetto fosse l’unico mezzo attraverso cui la persona poteva definirsi, dunque esistere. In breve: oltre la materia, non c’è niente. Neppure il bene e il male.
«Ancora attorno al diavolo potevano organizzarsi eresie e sette di magia nera. La nostra magia è invece bianca: nessuna eresia è possibile nell’opulenza. Ma eccoci di nuovo nel discorso triste e profetico, presi nella trappola dell’oggetto e della sua pienezza apparente. Ora noi sappiamo che l’oggetto è nulla, e che dietro di esso si aggroviglia il vuoto delle relazioni umane, il disegno a caldo dell’immensa mobilitazione delle forze produttive e sociali che vengono a reificarvisi. Attenderemo le irruzioni brutali e le disgregazioni improvvise che, in maniera tanto imprevedibile, ma certa, quanto il maggio del 1968, manderanno in frantumi questa messa bianca2» si augurava Baudrillard. La messa bianca dell’opulenza, in effetti, è andata in frantumi. Il regno incontrastato del possesso materiale si è indebolito per vari motivi, in primis per il fatto che il modello capitalista non potesse garantire, come promesso, il benessere di tutti, ma solo quello di pochi, a discapito di tutti. E poi, in maniera repentina quanto inaspettata, è arrivato il colpo di grazia: Internet. L’agente disgregatore. Il fattore dematerializzante per eccellenza.

© Felice Vino, Beetle
Un gravoso fardello
Che cos’è Internet?
Il termine è composto dall’abbreviazione e unione di due parole inglesi: (Inter)national e (Net)work. Si tratta di una rete di device, interconnessi tra loro, che consente lo scambio di informazioni e la comunicazione a livello globale. Siamo tutti connessi, questo è un dato di fatto; ma come singoli punti, che dalla propria individualità fanno sempre più fatica a uscire.
Nel romanzo d’esordio, Estensione del dominio della lotta, Michel Houellebecq racconta come e quanto la Grande Ragnatela («www» è un acronimo che sta per world wide web, ossia: «ragnatela estesa sul mondo») instilli in noi un senso di connessione illusoria, ma de facto ci allontani sempre più, tanto da renderci estranei tra gli estranei. Secondo Houellebecq, il crescente isolamento dell’essere umano è in larga parte dovuto al progresso tecnologico: oggi usiamo JustEat per mangiare, Tinder per cercare partner, Netflix per guardare film. Queste piattaforme ci permettono di fare quello che vogliamo restando chiusi in casa, liberandoci da ciò che viviamo come un gravoso fardello: la relazione umana.
La tecnologia, nata per sostenerla («aggiungimi su Facebook», «scrivimi su WhatsApp», «videochiamami»…), si è sostituita a essa, cambiandone la sostanza fino al punto di sopprimerla. Come? Equiparandola alle altre azioni routinarie che richiedono la tecnologia per essere implementate. Cosa distingue una call del capo da una telefonata tra amici? Niente. Sono impegni ugualmente fastidiosi nella nostra fittissima schedule di operose formiche interconnesse. Aumentano, allora, l’incomunicabilità, l’isolamento, il disagio esistenziale; aumenta il divario tra i vincitori, quelli che hanno soldi, successo e potere, e i vinti, quelli che non posseggono nulla di ciò che la società ritiene fondativo per distinguersi dalla massa e proclamare: ce l’ho fatta.
Internet ci ha fatto fare il salto quantico dal materiale all’immateriale: quello che conta oggi non si può empiricamente possedere, né toccare con mano; quello che conta oggi è volatile. Non abbiamo più un appiglio che possa dirsi saldo: non la relazione umana, quasi totalmente obliterata; non la famiglia, non la patria, non lo Stato, non la politica, non la religione e neppure l’oggetto, la messa bianca di Baudrillard: i vitelli d’oro a cui ci siamo votati nel corso del tempo sono stati abbattuti da secoli di evoluzione del pensiero umano, che ha saputo emanciparsi da tutto, brillantemente, ma non è riuscito a costruire una singola alternativa a ciò che ha ridotto in macerie. Persino la nostra identità è sempre più incomprensibile, plastica, difficile da dire. E allora, se non possiamo aggrapparci nemmeno a chi siamo (o crediamo di essere), quale soluzione ci resta per non essere portati via dalla corrente?

© Felice Vino, Nyan Cat
Celebrità 2.0
Secondo il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, le celebrità sono uno dei pochi punti cardinali ancora rintracciabili sulle nostre mappe di avventurieri alla deriva: (i) perché il pubblico (noi) pensa di poter imparare qualcosa di utile da loro; (ii) perché offrono al pubblico (a noi) parole per esprimere in modi facilmente intellegibili cose che sembrerebbero, altrimenti, ineffabili; (iii) perché, nel vuoto assordante lasciato dalla politica, le celebrità legittimano il dibattito su problemi privati travestendoli da questioni di pubblico interesse. Il mondo si divide in chi vuole ascoltare e chi vuole essere ascoltato; chi guarda e chi vuole essere guardato; chi è celebre e chi no. E le celebrità, nell’era di Internet 2.0, siamo tutti noi, o meglio: chiunque sia capace di fare personal branding sul piccolo schermo (quello del cellulare, non quello della tv), trasformandosi in contenuto fruibile, facilmente digeribile dalla massa.
Alison Hearn, docente della University of Western Ontario, nel 2008 affermava con inquietante lungimiranza che «il personal branding o self branding implica la costruzione autoconsapevole di una meta-narrazione e di una meta-immagine di sé attraverso l’uso di significati culturali e immagini tratti dai codici narrativi e visivi delle industrie culturali tradizionali. La funzione del personal branding è puramente retorica. Il suo obiettivo è produrre valore culturale e, potenzialmente, profitto materiale3».
Le parole chiave che definiscono il perimetro del personal branding sono: meta-narrazione del sé e attenzione – elementi che, sapientemente combinati tra loro, sono volti a generare profitto, in via diretta (monetizzare) o indiretta (farsi un nome per poi, un giorno, monetizzare). Siamo invischiati nelle spire di un capitalismo altro, mutato come un virus, svincolato dagli oggetti, dal possesso materiale, e, come afferma la giornalista Jia Tolentino, nutrito oltre misura dal nostro ego ipertrofico: «Viviamo nel mondo che questa rete ha creato, un mondo in cui l’egoismo è diventato l’ultima risorsa naturale del capitalismo4».
Jia Tolentino parla anche di quattro problemi da lei ravvisati nelle nostre nuove identità di internauti devoti al personal branding e alla capitalizzazione dell’ego: «Primo, il modo in cui Internet è costruito per allargare il nostro senso di identità; secondo, come ci incoraggia a sopravvalutare le nostre opinioni; terzo, come massimizza il nostro senso di ostilità; e, infine, come distrugge il nostro senso delle proporzioni5».
A questi problemi si aggiunge quello di un disperato bisogno di verità che sembra attanagliare gli utenti, sebbene i social siano l’ultimo posto in cui la verità andrebbe cercata. I social ci hanno insegnato che vince (i.e.: vende) chi è il più vero, quello che il pubblico percepisce come persona reale, in carne e ossa, al di là della mediazione dello schermo. Tralasciando la questione (quasi banale) del teorizzare l’esistenza di una verità più vera del vero che possa vivere dietro questo sempiterno schermo, soffermiamoci sulle qualità che un personaggio dovrebbe possedere per essere percepito come true, aderente alla persona che presumiamo esserci dietro la maschera.
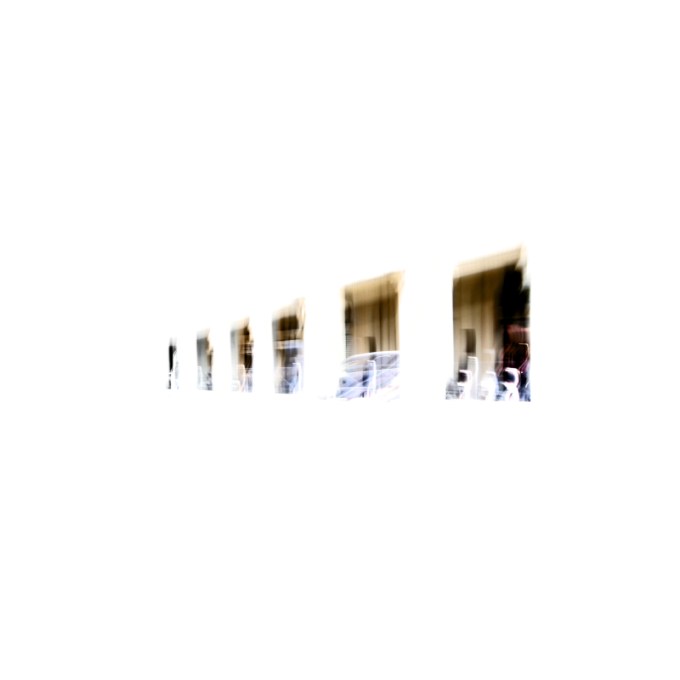
© Felice Vino, Rythm
Meno vero del vero
La risposta è semplice e ce la fornisce Tiziano Scarpa in La verità e la biro: nella grammatica di Instagram, Facebook e TikTok, gli attori (nel senso letterale di coloro che agiscono) sono come gladiatori gettati in un’arena feroce; l’arena sono i social e a noi, gli spettatori non più così passivi come ai tempi del predominio della televisione, è dato il diritto di alzare o abbassare il pollice. Pollice verso, in un mondo in cui l’attenzione è tutto, significa sparire dalle scene. Il sangue vende perché intrattiene; ci ha sempre divertito, sin dai tempi del binomio panem et circenses: ecco perché i social vogliono indurci a credere che essere caustici, maleducati e senza peli sulla lingua siano virtù cardinali, caratteristiche necessarie e sufficienti per potersi dire veri. I social sovrappongono violenza e verità, le mescolano, le confondono, e così ci tengono incollati allo schermo, illudendoci di poter diventare forieri di autenticità e schiettezza (gladiatori) o di poterle imparare guardando (spettatori). Di fatto, la grottesca pantomima a cui, scientemente o meno, ci prestiamo ogni giorno ha come unico obiettivo lo scontro, la miglior benzina per alimentare un’inestinguibile produzione di contenuti, interazioni, scrolling. Dunque: chi assume toni violenti e aggressivi è meno vero del vero, è il gladiatore perfetto, il personaggio più costruito che ci sia, partorito ad hoc dal nuovo capitalismo vorace di cui siamo vittime e complici per scontrarsi con altri gladiatori, versando il sangue a favore di like.
A questo punto, sorge spontanea la domanda: che fare?
Rimanere spettatori e godersi la consolazione del pollice verso? Convincerci del fatto che anche noi, in questa giostra mediatica che è diventata la vita, in fondo contiamo qualcosa?
Oppure: diventare celebrità, gladiatori assetati di attenzione, combattere per prendersela, quell’attenzione, perché, se l’attenzione finisce, finiamo anche noi?
E se gli spettatori esigessero la nostra testa? Saremmo in grado di sopravvivere alla morte del nostro io social, irreversibile anche se quell’io è virtuale?
«Può la mente umana dominare ciò che ha creato?» si chiedeva lo scrittore e filosofo Paul Valery.
Sì.
Uccidendo il nostro io social prima che ci uccida.
Abbandonare l’arena
Ho letto la profezia di Costar al mio ragazzo. Lo faccio sempre: lui detesta l’astrologia almeno quanto io mi diverto a farlo innervosire. Contro ogni previsione, Kill your personal branding gli è sembrato un vaticinio sensato. Sono troppo attaccata ai social, secondo lui, e questo non mi fa bene. Gli ho detto che, grazie ai social, ho conosciuto persone con cui ho instaurato legami duraturi; ho scoperto piattaforme con cui parlare delle cose che amo confrontandomi con un pubblico sempre più vasto; ho incontrato realtà culturali interessanti; ho partecipato a eventi, iniziative, festival; ho iniziato a memare e, intorno ai miei meme, si è creata una community con cui scambio chiacchiere, opinioni, pensieri. Insomma: i social non sono, di per sé, un male. È l’uso distorto che ci stiamo abituando a farne a renderli logoranti a livello mentale ed emotivo.
«Cos’è che trovi logorante?» mi ha chiesto.
Il dover essere sempre sul pezzo, altrimenti sparisci. Il dover avere un’opinione su tutto, anche su cose che non interessano direttamente a Claudia, ma piacciono agli altri, questa iraconda maggioranza digitale che si impone sul nostro volere più di quanto non facciano le persone in carne e ossa.
Mi logora che ogni opinione debba essere perfetta – il che, nel mondo dei social, non significa approfondita e basata su un attento studio del tema, ma, più semplicemente, schierata dalla parte giusta.
Il fatto che la parte giusta la scelgano gli altri, gli spettatori silenziosi, quelli che comodamente seduti sugli spalti decidono se girare il pollice o no, e magari cambiano idea il giorno dopo.
Mi logora il fatto che l’approvazione si conquisti anche e soprattutto sgomitando, ricorrendo alla voce grossa e alla violenza – cose che fanno parte di me molto più di quanto mi piaccia ammettere.
Unendo tutti questi puntini, ho pensato che Kill your personal branding significhi uscire dall’arena – il che non vuol dire necessariamente cancellare i propri account, ma sottrarsi al gioco perverso che ci vuole sempre presenti, sempre arrabbiati, pronti a darcele di santa ragione per difendere ideali che, nel peggiore dei casi, nemmeno ci appartengono. Il percorso per uscire dall’arena è lungo solo tre passi: per me, una persona assuefatta a tutt’altro pattern comportamentale, quei tre passi equivalgono a chilometri.
Primo passo: abbracciare la colpevolezza. Devo smettere di preoccuparmi della perfezione, imparando a godere di ciò che può macchiare l’immacolata immagine di celebrità virtuale che mi sono costruita. Dirò la cosa sbagliata? Starò zitta quando, secondo gli altri, avrei dovuto parlare? Mi cancelleranno? Mi crederanno cattiva? Ben venga. Meglio questo che essere un ingranaggio della macchina di controllo digitale che è diventato Internet mischiandosi al capitalismo, un apparato tentacolare a cui sembra impossibile sottrarsi, e che vede nei micro-influencer (tutti noi, ciascuno con il proprio pubblico) i suoi prodotti più riusciti.
Secondo passo: sposare l’incoerenza. I social premiano l’uniformità: più un profilo si ripete, producendo contenuti simili, facilmente catalogabili, più l’algoritmo lo rende visibile. Sarò felice di contraddirmi, in tal caso; e, se diventerò invisibile, sarà un dono: l’invisibilità è un superpotere. Voglio ragionare, approfondire, studiare; non voglio accontentarmi di hashtag e slogan da agenzia di comunicazione, le uniche cose che funzionano su Instagram. Se maturerò un pensiero, se vivrò un’esperienza importante, non vomiterò tutto quanto su Facebook costringendo le mie riflessioni a due righe sgangherate, attentamente pesate per non cadere in fallo. Voglio precipitare. Voglio smontarmi, farmi a pezzi, ricominciare a fare autocritica. Non ho sempre ragione. Le mie opinioni non sono in ogni caso le migliori.
Terzo passo: arrendersi all’irrilevanza. Voglio riassaporare il gusto di dire cose futili, di condividere una canzone o una foto solo perché mi piacciono anche se è l’11 settembre. Non voglio sentirmi obbligata a commentare il tema caldo del giorno sottolineando quanto sono buona, brava, retta, onesta, vi prego guardatemi sono una creatura unica e speciale. Sarò anacronistica, ma mi manca l’Internet anni Novanta basato sull’armonia, non sul conflitto. Il conflitto crea più attenzione, e, in un mondo in cui l’attenzione è denaro, più conflitto significa più soldi. Voglio riprendermi l’empatia, il dialogo, perché sono elementi antieconomici. Tutto ciò che il capitalismo non vuole.
Dopo aver fatto il terzo passo, sarò fuori dall’arena: un personaggio colpevole, incoerente e irrilevante non può essere un gladiatore. Non ne è degno. Allora, quel personaggio tornerà persona, e sarà relegato per sempre nelle terribili lande della vita vera, che non interessa più a nessuno.
Al momento sto ancora tentando di cambiare, e trovo molto più difficile muovere i miei tre passi su Facebook che su Instagram: su Instagram non ci sono io, ma solo i meme che creo; su Facebook, invece, tutto quello che posto è legato a doppio filo a Claudia.
Lascio qui due promemoria per me stessa, perché so che arriverà il momento in cui l’odore del sangue mi mancherà come al cacciatore manca la preda; in quel momento, quando starò per riprendere in mano la spada credendo che sia mio dovere tornare nell’arena, dovrò ricordare a me stessa alcune cose:
1. Un’azione online non equivale a un’azione offline. È bello postare parlando di giustizia sociale, rettitudine morale e quant’altro, a tratti è anche utile (quando serve a fare informazione), ma non può essere un alibi che ci solleva dal compito di sporcarsi le mani. Agire nella realtà che ci circonda per sostenere le cause in cui crediamo è necessario, sebbene, ad oggi, l’azione al di fuori dei social non generi un milionesimo dell’attenzione che un reel, una foto o un tweet sono in grado di catalizzare. Il sostegno esclusivamente virtuale, l’attivismo social performativo è (ancora una volta) mero, noiosissimo personal branding.
2. Meno io, più noi. L’io è arrivato addirittura a inquinare la politica, che dovrebbe essere il luogo per eccellenza in cui hanno voce le istanze sociali. Vivere in società è anche ascolto, mediazione, compromesso. Compromettere l’io con l’altro è forse l’azione più dissidente che si possa fare in questo presente incistato nell’egotismo: in un mondo in cui la dissidenza esiste solo come hashtag, ripartire dall’azione, dalla fecondità vivace del corpo, dalla contaminazione con ciò che al nostro corpo è estraneo, sembra l’unica strada per fuggire dalle maglie della Grande Ragnatela che ci avvolge, soffocando tutto ciò che eravamo, rendendoci ogni giorno meno umani. Più soli.
3. Non avere paura di uscire dalla zona di comfort, di riscoprire e abbracciare la propria vulnerabilità.
Questi consigli non sono di Costar, ma della mia adorata Brandy Alexander.
«Brandy dice: […] non fare quello che vuoi. Lei dice: fai quello che non vuoi. Fai quello che sei allenata a non volere. Il contrario della ricerca della felicità.Brandy mi dice: fai le cose che ti spaventano di più6».
Editing di Fabiana Castellino, correzione bozze Viola Carrara
Claudia Grande è nata a Chieti il 22/12/1990. Ha lavorato presso lo studio legale internazionale Gianni & Origoni. Ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense mentre concludeva un master biennale alla Scuola Holden. Oggi lavora in Rai Pubblicità come copywriter/content creator e tiene corsi di scrittura online. Bim Bum Bam Ketamina (Il Saggiatore, menzione speciale Premio Wondy 2024) è il suo primo romanzo.





Ex-Stasi è una serie di fotografie digitali a lunga esposizione, alla quale il poeta e artista Felice Vino ha lavorato nel 2018; è parte di un progetto dedicato alla visione artificiale, le cui differenti serie sono accomunate dalla ricerca sulla sensibilità estesa dalla e nella tecnologia.
Il tempo della lunga esposizione deforma le immagini e per mezzo della rielaborazione digitale, l’amplificazione di saturazioni, luci e contrasti, inizia l’esplorazione delle possibili visioni della macchina, delle possibili corrispondenze tra allucinazioni artificiali e allucinazioni sensoriali dell’umano.
È il movimento in uno spazio attraversato da frequenze visive che in postproduzione l’artista pone in dialogo con margini di vita interiore restituiti da dissezioni, interferenze, onirismi amorfi. Vino ci ricorda che ogni opera si manifesta come approssimazione rispetto alla visione, all’idea primaria.
Curva lo sguardo alla necessità di frapporre tra il soggetto e il mondo non solo filtri ottici, ma anche una riflessione metonimica sull’esperienza del reale che addensa i suoi possibili orrori e rivelazioni in una materia che sembra formarsi per espianto da un campo visuale più ampio, esteso nella sua componente psichica.
Maria Teresa Rovitto
Felice Vino. Nato a Potenza, negli anni ha sperimentato diverse forme espressive, scrittura, video, arte digitale. Ha scritto, diretto e prodotto, viaggiato, cambiato casa e vita, Potenza, Roma, Bologna, Milano. La poesia gli ha suggerito il percorso, il cinema lo ha mostrato, oggi lavora con le AI, i dati, la CGI e con qualsiasi strumento gli restituisca quel senso di meraviglia di fronte alle forme che possono assumere il bello e l’ignoto.
- Jean Baudrillard, La società dei consumi, Il Mulino, Bologna, 1976 ↩︎
- Ivi ↩︎
- Alison Hearn, Meat, Mask, Burden: Probing the contours of the branded self, in: Journal of Consumer Culture, 2008 ↩︎
- Jia Tolentino, Trick Mirror: Le illusioni in cui crediamo e quelle che ci raccontiamo, NR Edizioni, Pescara, 2020 ↩︎
- Ivi ↩︎
- Chuck Palahniuk, Invisible Monsters, Mondadori, Milano, 2000. ↩︎
1 Comment